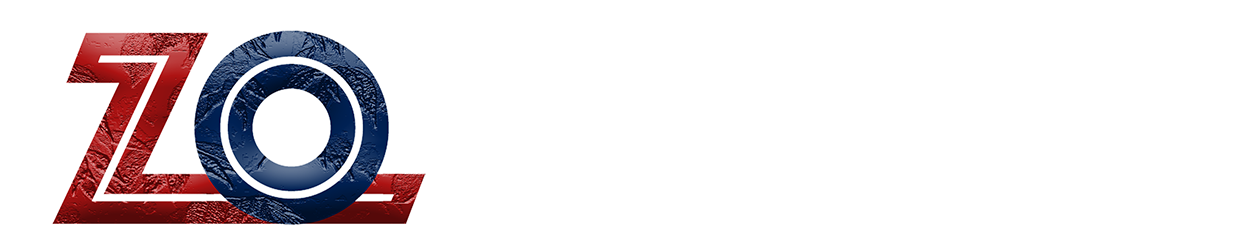Già pubblicato sulla rivista Mani future (gennaio 2002) sotto lo pseudonimo di Anonimo Butriense.
Stasera che pioggia e nevischio s’infilano sotto i portici bassi di Rivareno, appena passato San Carlo, sotto il lampione offuscato tal quale una volta, penso che Santarelli ha parato il rigore di Niers: lo ha parato ieri stesso o forse un secolo fa o forse chissà quando, intanto che vado di traverso per il centro in direzione San Vitale, come nella preistoria un pecoraio su una pista tracciata proprio qui sotto, verso la palude padana, o secoli fa un viaggiatore verso la Pentapoli, o giusto ieri uno della Bassa che s’appresta verso l’ultima corriera Bologna-Mordano.
Il fatto secondario è che ero nato sulla strada per Ravenna dalle parti di Budrio e siccome dalla mia scuola in Galliera si usciva sciamando a sera inoltrata, poi si gironzolava con qualche schiamazzo, poi si esplorava di qua e di là, noi della stessa zona andavamo alla stazione delle autolinee Giuliani, di cui Rossano l’autista era il re che, dicevano, somigliava a Burt Lancaster e da Bologna a Castel Guelfo le faceva piangere tutte quante.
Chissà dove vivono adesso le ragazze che amavano solo Rossano, al tempo che le sere, abbandonata la compagnia, giravo per Tanari Vecchia ed entravo da Ghitån, l’antro vero del mondo. Porta coi campanelli. Fumo di sigarette e fumigante cucina. Incessanti dispute in sala, a banco mulinare di gesti. Arcane battute da decifrare. Invettive in dialetto. Discorsi pontificali in italiano gergale. Gente nuova che arrivava. Altra che andava. Saluti gridati. Da Ghitån si diceva di tutto. Da Ghitån sapevano tutto.
Caligola era uno che parlava solo dialetto con grammatica di gesti e sentenze: sembrava vecchio di rughe e di peli bianchi sulla testa ma era stranamente dritto e proporzionato come un giovane, anche se un certo andamento sbilenco denunciava passati strapazzi. Non so se Caligola fosse il nome o il cognome, mentre Charlie, il suo ‘socio’, doveva aver preso il nomignolo dai film americani. Meno allampanato e più taciturno, vestiva gessato; aveva i capelli ondulati e sempre in ordine, una bella faccia regolare e un paio di baffi sottili. A volte portava la Giulia, la sua donna, a volte la riportava via. Anche lui parlava dialetto, ma quello che diceva aveva un peso. Solo Mauro Baccilieri poteva trattarlo alla pari e lo canzonava con allusioni e sarcasmi di cui lo scontato finale era sempre: «Lè lò al piò grand».
Mauro era un po’ più grande di me, ma già lo chiamavano a fare il pianista nei night. Veniva dal Solferino, dicevano, e quando non era in giro a suonare o filare dietro la figlia di M., l’industriale che occupava uno stabile da qualche parte d’Indipendenza, stanziava da Ghitån quasi di fisso. Ed era beffardo quando vinceva e quando perdeva a briscolatressette, massino o bigliardo, e anche quando non faceva niente e ordinava un Baby. Mi rapì una delle prime sere che mi avvicinai alla sua combriccola alla fine di una discussione di calcio, quando entrò il Charlie: «Té ti prezîs a Gatsby: t séllt fòra a la fénn», lo salutò ghignando Mauro. Nessuno capì la battuta e neanch’io, ma già sapevo dove andare a spulciare, la prossima volta che sarei entrato nella grande sala dell’Archiginnasio. Questo era Baccilieri, che quando non parlava di calcio parlava e sparlava di libri, mescolando paragoni e dispensando giudizi in sorvegliato italiano non meno che in tranciante dialetto: mezzali, terzini o venerabili autori, non faceva differenza.
La donna di Charlie, la Giulia, era ‘a parte’ e la prima volta che la vidi appresi a patire quella sottile sofferenza che sempre dà la bellezza femminile.
Lì dentro io ero semplicemente al biånd, e i più anziani sembravano accettarmi con negligenza ed affetto come di solito fanno gli animali coi cuccioli. Io però proprio a loro ero interessato, come se il senso di morte che incombe su tutte le adolescenze fosse pronto a portarseli via, e con essi il passato, il tempo e infine me stesso. Per questo tempestavo di domande Caligola e Charlie e tutti gli altri: «Com’era qui una volta?». Mi raccontavano che lì da Ghitån, prima della guerra, quando ti servivano la salsiccia la pagavi a metri mentre i fagioli li pagavi a ore. Quelli che poi andavano a casa ubriachi, la moglie li cacciava fuori e così tornavano a dormire in osteria. «E poi a morosa qui, dal Solferino o dal Broccaindosso non si veniva. Bisognava chiedere al parmàss», bofonchiava Baldazzi a sproposito dal tavolo di fianco, indicando Baccilieri mentre andava a busso. «Al chèp l îra ló» faceva spallucce Baccilieri indicando Caligola. E nell’ansia di recuperare tutto, io continuavo ad incalzare: «E prima che cosa c’era?».
Questo neanche Caligola lo sapeva. Sotto i neon affumicati io fissavo la nebbia e i lampioni e, ogni volta che si apriva la porta facendo oscillare un debole fascio di luce lungo le ginocchia unite della Giulia, mi ripetevo che perduto quel ricordo avrei perduto tutto: quel che era nella pianura, nella città, dentro di me e dappertutto. E fissando un punto nella connessione tra la colonna e il portico di legno, mi ripetevo che avrei dovuto ricordare quel particolare in eterno, ritornare dopo decenni e tener conto che lì era già capitato tutto e tutto era stato dimenticato. Perché Caligola e Charlie erano stati anche loro ragazzi nel Borgo delle casse, e quando non li rapavano a zero e non li portavano al Pratello inchiodavano delle zattere di legno e si buttavano a capofitto giù per la cascata del Cavaticcio sull’alveo del vecchio porto. Poi avevano fatto dell’altro.
Bombo
© Riproduzione Riservata