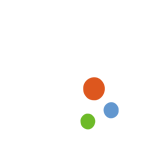La Flavia calabrese (ovvero Sulle vertiginose e infine insormontabili difficoltà del mestiere di traduttore)
Un bel giorno, anzi, una bella sera, decisi di tradurre in lingua calabrese nientemeno che quella pietra miliare della letteratura bolognese, quel testo della cultura escatologica del dialetto del capoluogo emiliano, che corrisponde al titolo de Al fatàz di Żardéṅ Margarétta, ovverossia La Flèvia, già riesumato dalla traduzione orale e commentato da Francesco Guccini nel 1991.
Nominare l’eschaton significa patire l’atteso ultimo compimento dei propri presupposti, tipo desiderare di andare in finale di Champions, o paventare l’ultimo rigore che ti condannerà. Significa insomma argomentare sulle le tue istanze più profonde.
Ma non è questo il tema del mio racconto-resoconto.
Non venitemi infatti a raccontare che a nessuno di voi, ad un certo punto del cammin, non sia scattato il rimpianto per cui gli sarebbe piaciuto fare nella vita tutt’altro che il proprio lavoro. E nient’affatto per opportunità di reddito, ma semplicemente per conferire senso felicità e allegria al proprio vivere quotidiano. Qualcuno avrà pensato che un niente gli precluse di essere calciatore, altro il cantante, altro il viaggiatore. Scherzando, io potrei dire che mi sarebbe piaciuto fare la vita del mio amico Zvanéṅ, che voi conoscete dai miei raccontini e di cui avevo in comune la virtute e la canoscenza apprese dal maestro Guståṅ, ma non l’avvenenza.
Ma siamo seri, a me sarebbe piaciuto di fare il traduttore.
Ve l’immaginate, per uno che spesso si arrabatta a fare lo scrittore, scansare la fatica di inventarsi le storie e di connetterle tra di loro, trovandole già fatte da qualcun altro che le ha scritte in un’altra lingua e tu devi solo tradurle, cioè accompagnarle, abbandonarti all’infinito piacere di travisarle e aggiustartele addosso. Però devi conoscere le lingue degli altri e almeno una devi conoscerla proprio per bene. La mia lingua madre è la lingua di Giulietta e Romeo. Non quella di Shakespeare, ma quella che ancora alza le sue grida in piazze delle Erbe a Verona. A cinque anni, con gli amici, imparai il bolognese. Ricordo che la pienezza del sapere, come aver superato con lode l’ultimo esame, scese su di me quando compresi d’un tratto la traduzione della parola mangereccia ‘prezzemolo’. L’inghippo stava nel fatto che ‘prezzemolo’ in bolognese si traduce prasôl, ma dalle mie parti, dialetto del nord-est, ‘prezzemolo’ da singolare diventa plurale, i presù, come dire ‘i prezzemoli’, ‘le erbette’.
Poi i miei mi destinarono al tecnico, perché si andava a lavorare prima. Lì imparai un po’ di francese. E infatti, mentre insegnavano fisica, io tenevo aperte sotto il banco le poesie di Baudelaire. Avete presente com’erano fatti i banchi di una volta, fino all’avvento del COVID, col buco del calamaio di sopra e la mensolina di sotto… Baudelaire ho provato anche a tradurlo, scoprendo che il modo migliore per rendere in italiano quella bile spremuta dal fegato del Nostro, era tradurlo letteralmente, pari pari, senza tentativi di adattamento. Provare per credere, naturalmente per chi ne abbia voglia. Più tardi, all’annunzio dei nuovi tempi, avrei tenuto sotto il banco Il Capitale di Carlo Marx, un librone alto quattro dita che andavo a prendere alla biblioteca di Budrio quando mi andavo a rifornire con un carriolino.
Perché tradurre La Flèvia in calabrese, tanto per tornare in tema, è presto detto: intanto perché il calabrese è quasi una seconda lingua tra quelle che echeggiano sotto le Due Torri; e poi perché avevo in quel momento come più fidata collaboratrice al locale, guarda caso, una brava calabresina. Come avrei potuto infatti cimentarmi da solo nel maneggio di una lingua italica, di quelle che il nefando Nino Bixio, braccio destro di Garibaldi, considerava addirittura lingue africane? Una sera c’era poco da lavorare, si scherzava e si bighellonava. Io non sono uno di quelli che ‘corre dietro ai collaboratori’: a volte per me il fare gnente fa parte integrante del lavoro.
«Allora – dico alla ‘bambina’, intelligente, scolarizzata e parlante più lingue straniere –, io traduco a te questo poema, riduttivamente chiamato zirudèla, scritto in ostica lingua gallica, e te ne svelo gl’intimi significati, naturalmente nei limiti dell’esplicazione verbale». Lei capisce, ha fatto filosofia e ha letto i sofisti, sa che le parole sono spesso vaghe ed ambigue e che quello che sta al fondo della realtà non è sempre esprimibile.
«Quindi – continuo – tu dovresti traslare le immagini che io ti evocherò nella tua cultura ancestrale e trasfonderle, cioè restituirmele, nella tua lingua materna».
Così ha inizio l’esperimento. Cominciamo dai versi 23 e 24, che presentano il primo personaggio. I due versi sono molto semplici, descrivono un dato oggettivo e, se fossero espressi nel linguaggio ciclistico del giro d’Italia, potrebbero definirsi due tappe di trasferimento:
L’è Vittóri un bèl żuvnòt,
impieghè int un bänc dal Lòt.
È Vittorio un bel giovanotto,
impiegato in un banco del Lotto.
La traduzione in calabrese è lineare e immediata:
Le’ Vittorij nu’ bell’ giuvinott,
ch fati’jd nda’ puti’h du’ Lott.
I versi 41 e 42 presentano invece il secondo personaggio, nientemeno che la Flèvia, la Flavia, il personaggio femminile. Qui incontriamo la prima difficoltà, che potremmo definire, se ci è consentito, difficoltà di primo grado, incontrando ostacoli puramente linguistici. Ostacoli tutt’altro che trascurabili tuttavia, perché riguardanti espressioni che, comuni in una lingua, possono essere non contemplate in un’altra:
Flèvia, invézi, è una spuṡlòta
che a un bån câz l’aj sa tgnîr bòta.
Qui incontriamo il termine spuṡlòta, che significherebbe ‘signora non più giovanissima e piuttosto in carne’. Come notammo subito, l’effetto evocativo si perdeva completamente nella traduzione in italiano. Anche in calabrese non esisteva un termine corrispondente e tutto quello che Cristina riuscì a trovare fu fimmena spusèta. Poi c’è la locuzione tgnîr bòta. Tenere botta. Questa è una espressione mutuata dalla falegnameria e significa che se un falegname o un fabbro batte col martello, bisogna che dall’altra parte un altro faccia opposizione se no l’oggetto si sposta. In italiano viene usata nel senso figurato di ‘resistere’ ma qui, nel poema in considerazione, è inteso proprio nella sua operatività tecnica, diciamo pure corporale. Purtroppo, in calabrese, la locuzione non esisteva o, quantomeno, Cristina non la seppe trovare. Tutto quello che le riuscì di escogitare per la traduzione fu di trasformare un’immagine concreta in una propensione spirituale:
Le’ Flavij na’ christijen chiatta
ca alla marge’h sa’ sind’d
È la Flavia una signora un po’ grossa
che a quelle cose si sente di rispondere.
L’effetto non è esattamente lo stesso!
Ma è ancora niente rispetto alla la difficoltà che si presenta coi versi 25 e 26, ove si specificano le qualità precipue del personaggio Vittorio:
Péin ed vétta e péin’d calûra,
e con l’ôca sàmper dûra.
E qui credo che si esemplifichi la più insormontabile difficolta per il traduttore. Infatti, la versione in italiano sarebbe:
Pieno di vita e pieno di eccitazione,
e con il membro sempre in erezione.
L’impossibilità della traduzione dal bolognese al calabrese non è di ordine semplicemente linguistico, bensì profondamente culturale. Cristina infatti sulle prime si rifiuta, poi mi dà un’imbarazzata traduzione letterale:
Bi’ll bi’ll e chi’in i muund,
teen’ semp uh’ cazz ti’is.
Per poi concludere con questa decisa spiegazione: «Mentre per voi bolognesi è allegro e divertente pensare che uno se ne possa andare in giro sempre col ‘coso’ in erezione, per un calabrese sarebbe mortificante, ne va della sua determinazione personale. Non deve un individuo farsi condizionare dalla natura, ma bensì lui stesso, a tempo debito, decidere il quando e il come».
Non so se questa ‘spiegazione’ sia davvero valida nel caso in questione, ma è certo che qui si tocca con mano come certi coinvolgimenti emozionali che hanno pregnanza e validità ad una certa latitudine, non ne abbiano altrettanta in un’altra. Ovvio che questa estraneità faccia capolino in tutta evidenza quando si traducono poi i motti di spirito e i doppi sensi. Io non ho mai riso per esempio alle battute di un monumento come il Falstaff, scritto in un inglese già intraducibile anche per la Regina, non dico per il Re Carlo III; così come non mi ha mai convinto la versione in italiano del Tom Sawyer e di Huckleberry Finn pubblicate nel 1979 dal grande Gianni Celati, amico mio, e giù giù fino ai doppiaggi dei film americani di cui mi sono nutrito da ragazzo. Sia chiaro che non sono inconsapevole dell’altro capo del ragionamento, ci mancherebbe. E cioè che esiste una sola possibilità per potersi affacciare alla finestra del mondo e della letteratura in altra lingua: la traduzione.
Forse ho finito per scoprire una cosa risaputa e banale, diciamo pure la scoperta dell’acqua calda. Ma in definitiva la leggerezza di Vittorio, dopo aver celebrato la sua epifania ai giardini Margherita, ameno laghetto alimentato dal Sàvena, mi ammonisce sugli ostacoli che avrei incontrato in quel mio mancato mestiere.
Bombo
© Riproduzione Riservata
Foto: ebay.it